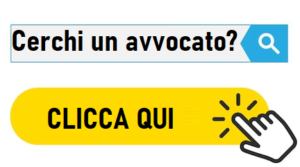L’avvento dei Social Network ha, senza dubbio, stravolto le nostre abitudini determinando il passaggio dal “web 1.0” al “web 2.0”.
Per “web 1.0” si intende quella dimensione statica che rappresenta la prima fase dell’uso di internet e che permetteva all’utente esclusivamente, di visualizzare i contenuti, senza avere la possibilità di modificarli o inserirne ulteriori; mentre per “web 2.0” si fa riferimento ad una dimensione dinamica, nella quale l’utente è contemporaneamente creatore e fruitore dei contenuti.
Vedi anche: Offese sui social network: reato di diffamazione e risarcimento del danno
I social network, infatti, garantiscono la partecipazione dell’utente attraverso tre modalità:
– gli utenti sono invitati a fornire dati personali allo scopo di generare una descrizione di se stessi o meglio il proprio “profilo”;
– gli utenti possono pubblicare il proprio materiale (come una fotografia o un post di diario, musica o videoclip o collegamenti ad altri siti);
– gli utenti hanno la possibilità di creare una lista di contatti con cui interagire[1].
I numeri che negli anni sono stati raggiunti e collezionati dai social network provano senza dubbio la condotta partecipativa degli utenti che pubblicano contenuti, partecipano con commenti o like, scelgono le pagine e i personaggi da seguire, supportare o screditare.
Il Corriere.it nel 2013 ha fornito una serie di dati, relativi ad un’indagine effettuata dall’Americana Qmee, volti a descrivere cosa avviene on-line in un minuto.
I dati di Instagram parlavano di 8.500 like e 3.600 foto al secondo.
Anche i dati di Facebook parlavano chiaro: 41.000 post al secondo e di 1,8 milioni di “mi piace” ogni sessanta secondi.
Per Twitter, invece, si parlava di 278.000 tweet al minuto, mentre il colosso della messaggistica istantanea, WhatsApp, contava circa 42 milioni di messaggi scambiati ogni minuto.
Dal 2013 ad oggi l’utilizzo delle piattaforme social è aumentato in modo esponenziale. Ne sono nate di nuove e i giovanissimi si sono sempre più avvicinati a tali meccanismi. Si consideri che TikTok, l’App che spopola tra i più piccoli e che nel “lontano” 2013 neanche esisteva, tra il 2018 ed il 2019, solo in Italia, ha avuto una crescita del 388%.
Facebook, invece, che nel 2013 contava, esclusivamente in Italia, 21milioni di utenti dei quali 13milioni quotidianamente connessi, a maggio 2017 contava 30 milioni di utenti attivi ogni mese, di cui 24 milioni collegati ogni giorno, fino ad arrivare, nel 2019 a 35.900 milioni di utenti mensili[2].
I dati riportati ci inducono, inevitabilmente, a riflettere sul contenuto di ciò che quotidianamente viene caricato on-line.
Un maggiore utilizzo del web ed una rilevante partecipazione ai canali social hanno, conseguentemente, determinato un aumento esponenziale delle offese alla reputazione, all’onore ed alla riservatezza altrui.
On-line possono verificarsi due differenti condotte[3]:
- Le offese potrebbero essere, ad esempio, mosse via chat alla presenza della vittima. In questo caso si parlerà di INGIURIA. A partire dal 2016 il reato di ingiuria è stato depenalizzato, per cui chi assume tale condotta compie un illecito civile e sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti della vittima;
- Se le offese, al contrario, sono mosse senza che la vittima possa immediatamente percepirle, ad esempio perché assente, si parla di DIFFAMAZIONE. Sul punto si sottolinea che la Cassazione ha avuto modo di ritenere che l’offesa mossa pubblicamente attraverso una piattaforma social integra il reato di diffamazione aggravata data la capacità dei social network di raggiungere un elevato numero di utenti: “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico” ( pen. n. 24431/2015 – Cass. pen. n. 4873/2017).

Nel tempo abbiamo assistito a diversi casi di offese rese via social, il più recente ha coinvolto Liliana Segre che è stata bersaglio di una serie di commenti offensivi, pubblicati sotto ad un post diffuso dalla pagina Facebook del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ritraeva la Senatrice sottoporsi al vaccino anti Covid-19. Non è la prima volta che la Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, viene attaccata dagli “odiatori del web”: dal novembre 2019, dopo una serie di minacce ricevute via web, la Senatrice è accompagnata in ogni suo spostamento da Forze dell’Ordine.
Un ulteriore esempio emblematico è quello di Claudia Alvernini, la 29enne infermiera dello Spallanzani, che per prima si è sottoposta al vaccino anti Covid-19. La donna ha dovuto chiudere i suoi profili social perché inondata da critiche, insulti, e minacce.
Ancora, si pensi a Silvia Romano, la volontaria milanese tenuta in ostaggio per circa 500 giorni, che una volta liberata e tornata in Italia ha visto i suoi profili social ricchi di insulti e veleni.
Al di là di questi casi limite, che ci portano senza dubbio a riflettere anche sull’etica e la morale di molti individui, dal punto di vista strettamente giuridico non possiamo non riconoscere l’impegno della Giurisprudenza nel definire una serie di ipotesi che possono verificarsi on-line.
La Cassazione, ad esempio, con la Sent. n. 3148/2018 ha escluso la diffamazione laddove siano denunciati, attraverso un commento social, i prezzi troppo alti di un locale, accusandolo anche di truffare sul peso del cibo offerto. In tal caso, constatata la verità del fatto storico, il soggetto che ha pubblicato tale commento ha esercitato, a giudizio della Corte, diritto di critica seppure utilizzando espressioni al limite della continenza, perché “il linguaggio, figurato e gergale, nonché i toni, aspri e polemici, utilizzati dall’agente sono funzionali alla critica perseguita, senza trasmodare nella immotivata aggressione ad hominem. Il requisito della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto dell’utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, hanno però anche significati di mero giudizio critico negativo del quale occorre tenere conto anche alla luce del contesto complessivo e del profilo soggettivo del dichiarante (Sez. 5 n. 42570 del 20/06/0218, Concadoro, non massimata)”.
Ancora, la Corte, dopo aver ribadito il principio di cui sopra relativo alla diffamazione aggravata via social, con la Sent. n. 40083/2018, ha precisato che, nel caso in cui il contenuto lesivo sia in un commento pubblicato sulla bacheca Facebook della persona offesa, “l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive” non consente comunque di “mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria” (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Nastro, Rv. 254044).
La Corte, inoltre, con la Sent. n. 34145/2019 ha chiarito che «è vero che la recente giurisprudenza di legittimità ha mostrato alcune “aperture” verso un linguaggio più diretto e “disinvolto”, ma è altrettanto vero che talune espressioni presentano ex se carattere insultante». Dunque, la Cassazione ha ritenuto “obiettivamente ingiuriose quelle espressioni con le quali si “disumanizza” la vittima, assimilandola a cose o animali. Paragonare un bambino a un “animale”, inteso addirittura come “oggetto” visto che il padre ne viene definito “proprietario”, è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo e scaduto il livello espressivo soprattutto sui social media, conserva intatta la sua valenza offensiva”.
Quanto, invece, al destinatario della condotta diffamatoria, la Corte di Cassazione con una pluralità di pronunce ha sottolineato che si integra il reato in discorso anche laddove la vittima non sia identificata in modo chiaro purché sia identificabile. In particolare, la Cassazione con Sent. n. 30369/2012 ha ritenuto che “non occorre che l’offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l’offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva, tra una categoria di persone”. Ancora con la Sent. n. 49066/2015 la Corte ha ritenuto diffamatoria la condotta di un militare che aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook tra i suoi dati personali il seguente messaggio: “…attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo … ma me ne fotto … per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie”. In tal caso, si ritenne che “le espressioni utilizzate e inserite nel detto profilo, erano tali da consentire la individuazione del loro destinatario per essere ‘vestite’ da riferimenti soggettivi (‘collega’), temporali (‘attualmente’), motivazionali (incorsa ‘defenestrazione’ per ‘l’arrivo del collega’), personali (stato coniugale)”.
Al di là del profilo strettamente penalistico, contro le offese alla propria reputazione ricevute on-line sarà possibile agire anche in sede civile. La vittima avrà la possibilità di intraprendere un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., prima ancora di dar vita ad un giudizio volto al risarcimento del danno, per ottenere la cancellazione del contenuto lesivo. In tal caso però è necessario porre una distinzione tra i contenuti caricati su un social network da un utente e quelli invece facenti capo a riviste online. La Cassazione ha avuto modo di sottolineare tale differenza affermando che “la tutela costituzionale assicurata dall’art. 21, co. 3, Cost. alla stampa si applica al giornale o al periodico pubblicato, in via esclusiva o meno, con mezzo telematico (…) Ne consegue che, ove sia dedotto il contenuto diffamatorio di notizie ivi pubblicate, il giornale pubblicato, solo o anche, con mezzo telematico non può essere oggetto, in tutto o in parte, di provvedimento cautelare preventivo o inibitorio, di contenuto equivalente al sequestro o che ne impedisca o limiti la diffusione, ferma restando la tutela eventualmente concorrente prevista in tema di diffusione dei dati personali” (Cass. civ., SS.UU., 18/11/2016, n° 23469).
Per quanto riguarda il piano meramente risarcitorio, invece, il Tribunale di Vicenza (sentenza n. 1673/2020) ha riconosciuto ad un agente della Polizia Municipale un risarcimento del danno non patrimoniale pari a 15.000 euro per l’offesa alla sua dignità e reputazione ricevuta via Facebook. In particolare, un cittadino aveva pubblicato, sulla propria pagina Facebook, la multa ricevuta dalla compagna con la seguente didascalia: “”ieri alle 12:10 i sig. Ag. Sc. … e Ag. Sc … hanno verbalizzato questo verbale alla mia convivente, l’art.173 parla della guida al veicolo con l’uso del cellulare. Allora ditemi se io ieri avevo il cellulare della mia donna, cosa hanno visto questi due agenti di polizia municipale? Sapendo che fanno uso ed abuso di alcool, come mai sono ancora in servizio? ….. e ….., vi auguro che i vostri figli muoiano, della peggior malattia esistente sulla terra. Questo è quello che vi meritate, pezzenti, alcoolizzati e tossici. Amen.”
Il Tribunale, nel condannare il convenuto, riprendendo quanto stabilito dalla Cassazione con la Sent. n. 6481/2012, riportava un importante principio dal punto di vista strettamente probatorio, ritenendo che: “E’ possibile quindi utilizzare dei criteri presuntivi di verificazione del danno non patrimoniale in seguito alla diffusione di uno scritto attraverso Facebook, idoneo a diffondere il messaggio pubblicato lesivo, anche attraverso il sistema delle c.d. condivisioni, ben oltre la cerchia dei c.d. amici del titolare del profilo (Tribunale di Potenza n.864/2018). Pertanto, pur tenendo presente il generale principio che condiziona all’assolvimento dell’onere di allegazione e di prova il risarcimento del danno di qualsivoglia natura, anche non patrimoniale, si deve riconoscere che la prova del danno può anche essere data ricorrendo all’elemento notorio e alle presunzioni. Ne consegue che si può presumere che la lesione della reputazione arrecata per mezzo di un veicolo di comunicazione così capillare come è il social network Facebook, che raggiunge un ampio pubblico e che volutamente il convenuto ha permesso con la diffusione capillare data dalla tipologia di post pubblicato (pubblico), abbia arrecato alla persona offesa una sofferenza morale meritevole di ristoro. L’ automatismo del nesso causale è di tale evidenza da farsi che il relativo onere di allegazione possa riferirsi soddisfatto attraverso il richiamo al contenuto e alle modalità di diffusione delle affermazioni lesive”.
Con l’avvento dei social network non si sono incrementate esclusivamente condotte diffamatorie e ingiuriose ma sono nati nuovi fenomeni per i quali è stato necessario l’intervento legislativo. Uno tra questi, particolarmente legato all’ “era digitale”, è il CYBERBULLISMO.
Nel tempo abbiamo fatto i conti con diverse tipologie di bullismo ma con l’ampiezza del web e l’assenza di confini questo fenomeno è tornato ad imporsi in modo sempre più significativo. La differenza principale, infatti, tra il bullismo tradizionale e il cyberbullismo risiede proprio nell’assenza di limiti temporali e fisici. Mentre prima le condotte riconducibili al bullismo potevano realizzarsi esclusivamente laddove ci fosse una situazione di contatto tra il bullo e la vittima, oggi non sussiste più tale limite, potendo il bullo agire contro la vittima in ogni dove grazie al web.
Per far fonte a tale triste fenomeno è stata istituita la legge n. 71/2017 che all’art. 1 fornisce la definizione di cyberbullismo:
«Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
Il fenomeno si può articolare e manifestare in una pluralità di modi:
FLAMING à Pubblicazione, on-line, di messaggi particolarmente ostili;
HARASSMENT à Reiterato invio di messaggi offensivi, volgari, aggressivi e minatori, via SMS, e-mail, chat ecc…;
DENIGRATION à Diffusione di pettegolezzi, spesso inventati, finalizzati ad offendere, diffamare e a violare la riservatezza della vittima;
IMPERSONATION à Appropriazione delle credenziali di accesso ad una piattaforma social, o creazione di un profilo falso, attraverso il quale l’agente finge di essere la vittima e avvia una serie di attività finalizzate a metterla in cattiva luce o ad offenderla;
OUTING AND TRICKERY à Diffusione, senza il consenso della vittima, via social o attraverso pubblicazioni on-line, di immagini intime o altro materiale sensibile della vittima, come ad esempio confidenze spontanee salvate o registrate, ricevuti direttamente dalla vittima o, comunque, realizzati con il suo consenso.
Il bullo attraverso tali condotte potrebbe integrare diverse tipologie di reato, si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla diffamazione, alla minaccia, all’istigazione al suicidio e così via.
Sul piano civilistico, invece, sarà possibile agire per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla vittima a causa delle condotte riconducibili al “cyberbullismo”. Anche su tale punto, la Cassazione è intervenuta per fornire chiarezza su alcuni degli aspetti più complicati del fenomeno, in particolare l’ipotesi in cui la condotta sia assunta da più soggetti. In tal caso la Corte ha ritenuto che ci sarà una responsabilità solidale, condivisa tra tutti coloro che hanno preso parte all’episodio, indipendentemente dal ruolo svolto da ciascuno di essi (Cassazione civile Sent. n. 18899/2015). Si aggiunga che, essendo, generalmente, autori di tali comportamenti minori, la responsabilità potrà sorgere in capo ai soggetti tenuti alla vigilanza e alla educazione (art. 2048 cod. civ.).
L’art. 2 della l. 71/2017 invece si occupa di definire i rimedi attuabili nel caso in cui un soggetto sia vittima di cyberbullismo. In particolare, la norma prevede che:
«ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL, non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l’interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
Il legislatore italiano ha, quindi, attribuito ampi poteri al Garante per la protezione dei dati personali in quanto semmai i genitori o il minore (sopra i 14 anni) non riuscissero ad ottenere una risposta dalla piattaforma, ai fini della rimozione del video o del post denigratorio, possono rivolgersi al Garante, con un format molto semplice, essendo presente un modello sul sito dell’Autorità stessa. Il Garante può rispondere entro 48 ore, ordinando alla piattaforma di rimuovere il contenuto laddove si integrino gli estremi di cui alla legge n. 71/2017. Sul punto si rammenta un’importante considerazione di Antonello Soro (presidente dell’autorità garante per la protezione dei dati personali dal 19 giugno 2012 al 28 luglio 2020) secondo cui, se da un lato 48h possono essere un’infinità per la vittima, per chi deve agire sono davvero poche specie quando si tratta di identificare i titolari di siti registrati all’estero e imporre loro la rimozione attraverso procedure lunghe e complesse[4].
L’Autorità Garante si è sempre mostrata molto attenta alla tutela dei minori. A dicembre, infatti, era stata aperta un’istruttoria nei confronti della piattaforma TikTok per fare chiarezza su una serie di aspetti problematici tra cui la facile agirabilità dell’età anagrafica necessaria per iscriversi alla piattaforma. Il famoso social non ha fatto in tempo a fornire le proprie risposte che è stato al centro dell’ennesima tragedia: una bambina di appena 10 anni a gennaio ha infatti perso la vita per partecipare ad una tra le tantissime challenge virali su TikTok.
In questa occasione il Garante ha ordinato alla piattaforma di bloccare tutti i profili italiani chiedendo l’indicazione della data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’App, con conseguente rimozione di tutti gli account di soggetti di cui è dubbia l’età.
In Italia, infatti, i minori non possono prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, tra cui rientrano anche i social network, se non hanno compiuto il 14esimo anno di età.
Per far fronte alla sempre più massiccia presenza di minori online e per scongiurare i pericoli ad essa connessi, Pasquale Stanzione (Presidente del Garante per la protezione dei dati personali) ritiene doveroso “agire su due fronti: la responsabilità primaria e preventiva rispetto all’accertamento dell’età degli utenti e quella secondaria relativa all’obbligo di rimozione di contenuti illeciti, perché, ad esempio, istigano al suicidio”[5].
L’azione di rimozione dei contenuti dai social network, perché illeciti, trova però un forte limite nella circostanza per cui queste piattaforme, nonostante non possano considerarsi semplici «host provider», non sono assoggettati ad un obbligo generale di sorveglianza ex ante sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite (Articolo 17 del decreto e-commerce, d.lgs 70/2003).
Non possono però trascurarsi gli obblighi che il social ha, ex post, essendo civilmente responsabile del contenuto nel caso in cui, nonostante la richiesta dell’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non impedisca prontamente l’accesso al contenuto illecito, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non provveda ad informarne l’autorità competente (Articolo 16 del decreto e-commerce, d.lgs 70/2003).
In tal senso si è mosso il Tribunale di Napoli Nord nella triste vicenda che ha visto coinvolta una giovane napoletana, Tiziana Cantone. In tale occasione, infatti, il Tribunale affermava che: “pur in assenza di un generale obbligo di sorveglianza ovvero di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite […] deve tuttavia ritenersi sussistente una responsabilità per le informazioni oggetto di memorizzazione durevole od ” hosting” laddove, come avvenuto nel caso di specie, il provider sia effettivamente venuto a conoscenza del fatto che l’informazione è illecita (art. 16, comma 1, lettera b citato) e non si sia attivato per impedire l’ulteriore diffusione della stessa” (Tribunale Napoli Nord, ordinanza 3 Novembre 2016, relativa al procedimento n. 9799/2016). Il giudice non riconoscendo l’obbligo di controllo preventivo, ha comunque previsto, anche senza la sussistenza di un provvedimento ad hoc, in capo al provider l’onere di attivarsi per la cancellazione dei dati ogni qualvolta abbia avuto conoscenza della illiceità degli stessi; se il provider non si comportasse in tal senso ci sarebbe una sua responsabilità per i contenuti caricati sul proprio spazio da soggetti terzi.
Una tale responsabilità, come affermato, precedentemente, dalla giurisprudenza sarà, però, ravvisabile esclusivamente “allorché il danneggiato dimostri in giudizio che il provider era comunque stato messo a conoscenza del contenuto illecito di un’attività o di un’informazione alla quale dava accesso e che, nonostante ciò, non si sia attivato per darne tempestiva comunicazione all’autorità, né abbia provveduto ad impedire prontamente l’accesso a quel determinato contenuto, avvalendosi del potere di autotutela negoziale di cui avrebbe potuto avvalersi in base al contratto concluso con il destinatario del servizio”[6].
Anche la Corte di Cassazione, confermando la condanna per concorso nel reato di diffamazione del gestore di un sito Internet che non aveva rimosso il contenuto pur avendo avuto conoscenza, su segnalazione della vittima, del carattere diffamatorio dello stesso, ha avvalorato l’obbligo per gestori dei siti di rimuovere ogni contenuto offensivo di cui siano venuti a conoscenza (Cass. pen. Sent. n. 54946/2016).
La Corte, ancora, nel ritenere che l’amministratore di un blog può rispondere dei contenuti diffamatori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività degli stessi, li mantenga consapevolmente, ha in aggiunta considerato che dal punto di vista della responsabilità degli ISP c’è stato un rilevante sviluppo giurisprudenziale che non è stato accompagnato da un intervento normativo adeguato. La frammentarietà delle fonti e degli interventi in materia, infatti, non rendono semplice un’analisi sistematica delle fattispecie che vedono coinvolte le diverse tipologie di provider e l’atipicità delle loro attività, che presentano dinamiche e problematiche differenti (Cass. Pen, Sent. n. 12546/2019).
La nuova bozza di Regolamento, presentata dalla Commissione europea lo scorso 15 dicembre, ribadisce l’assenza di un obbligo preventivo di sorveglianza ma contempla la presenza di meccanismi che permettano agli utenti di segnalare contenuti illegali presenti sulla piattaforma.
L’obbligo delle piattaforme di eliminare il contenuto lesivo, conosciuta l’esistenza dello stesso attraverso la segnalazione privata, resta un elemento particolarmente problematico, potendo sfociare tale condotta, se non bene esercitata, in una violazione della libera manifestazione del pensiero.
Marta Strazzullo
[1] Tale definizione è stata resa dal Gruppo dei Garanti Europei, ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Opinion 5/2009 on online social networking, Adopted on 12 June 2009 per il cui testo si rinvia al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/10704/WP+163.+Opinion+5+2009+on+online+social+networking.pdf
[2] Per l’analisi si rinvia al seguente link: https://vincos.it/osservatorio-facebook/
[3] “Va rammentato che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore (Sez. 5, n. 10313 del 17/01/2019, Vicaretti, Rv. 276502)”. –Corte di Cassazione Sentenza 31 marzo 2020, n. 10905.
[4] F. Lo Dico, “Ancora troppo odio sul web, ma ora si può agire in 48 ore”, Soro: attendiamo segnalazioni per intervenire. Intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, “Il Mattino”, 15 gennaio 2018.
[5] F. Ognibene, Social & minori. Il Garante: TikTok, decisivo accertare l’età di chi li frequenta. È l’ora di regole efficaci per l’attività delle piattaforme digitali seguite dai più giovani Dopo la tragica fine di Antonella, 10 anni, parla Pasquale Stanzione, Garante per la privacy. Intervista a Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Avvenire, 23 gennaio 2021.
[6] Cfr., in tal senso, ordinanza del 3.10.2013, Tribunale di Milano, sezione prima civile. Riportata in Tribunale Napoli Nord, ordinanza 3 Novembre 2016, relativa al procedimento n. 9799/2016 http://www.iurisprudentia.it/public/sentenze/636140668276866250_ord%20031116%20reclamo%20facebook.pdf.